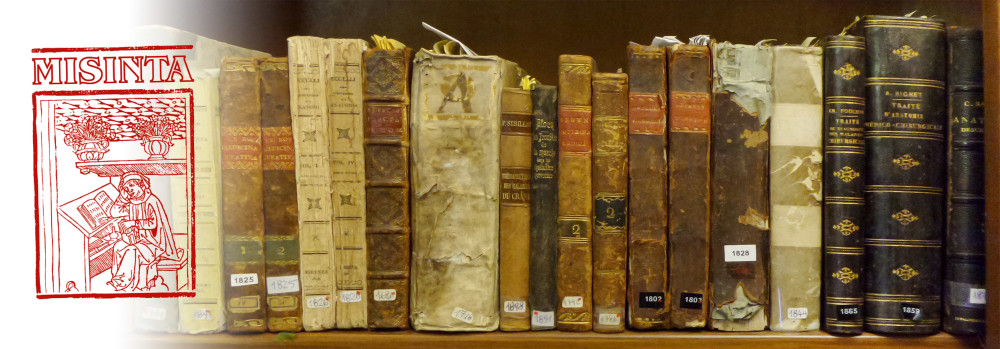MISINTA, Bernardino note tratte da Paolo Tinti – Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 75 (2011)
MISINTA (Misintis), Bernardino. – Nacque a Pavia (o in qualche centro del territorio) intorno agli anni Settanta del Quattrocento; non si hanno notizie sulla famiglia e la formazione. È noto anche con il soprannome di Ticinese, legato alla città d’origine.
Giunse a Brescia poco prima dell’8 ott. 1490, allorché diede alle stampe le Regulae grammaticales di Guarino Veronese, dopo aver stipulato una societas con il patrizio veronese Cristoforo Piacentini. Pur non essendo censiti lavori tipografici antecedenti, fu verosimilmente nel Ducato di Milano, a stretto contatto con l’ambiente universitario pavese, che il M. dovette apprendere i rudimenti dell’arte tipografica. L’avvio della stamperia a Brescia, nel territorio della Repubblica di Venezia, non fu facile; da subito il M. venne infatti attratto nell’orbita dei fratelli Angelo e Iacopo Britannico, i maggiori editori, tipografi e librai della città, i quali tentarono di mantenerlo in posizione di loro subalterno, contribuendo a rallentare il ritmo di produzione dei suoi torchi, sino ad arrestarlo del tutto. A questo difficoltoso periodo iniziale va comunque ascritta l’edizione dell’operetta devozionale in volgare Il pianto della Vergine Maria di Enselmino da Treviso (Enselmino da Montebelluno), risalente all’inverno 1490.
L’inizio di una nuova stagione per l’attività della stamperia è sancito dalla pubblicazione delle Gramaticae institutiones dell’umanista bresciano Cristoforo Barzizza, dedicate al nobile, pure bresciano, Ludovico Martinengo: a tale destinatario fu riservata una tiratura speciale dell’opera, impressa in alcuni esemplari su pergamena, supporto che attesta la maturità della perizia tecnica del M. e del suo socio. A seguito di un probabile accordo con i Britannico, il M. e il socio si spostarono a Cremona, città del dominio sforzesco da un ventennio priva di tipografia, dove si stabilirono nel giugno 1492. Qui, adoperando attrezzature tipografiche cedute in via definitiva o temporanea dagli stessi Britannico, impressero il De remediis utriusque fortunae di Petrarca e altri scritti d’ampia diffusione. Nell’autunno del 1493 il M. sciolse ogni legame con Cesare da Parma, rimasto a Cremona, e ritornò a Brescia, forse su invito dei Britannico, per i quali stampò numerose edizioni sino al 1502. I Britannico detenevano il monopolio editoriale bresciano e il M. impresse per loro il Sallustio del 13 genn. 1493; le Laudi di Leonardo Giustiniani, quelle di Iacopone da Todi, il s. Bonaventura, l’Esopo con la traduzione volgare interlineare in carattere di corpo minore, tutti stampati nel 1495; le Elegantiole di Agostino Dati, le Annotationes di Filippo Beroaldo il Vecchio, unite a scritti di Poliziano, di Domizio Calderini e di Giovanni Battista Pio, edite il 17 dic. 1496.
Avvantaggiato dalle numerose commesse ricevute dai Britannico, da cui derivavano cespiti sicuri, il M. tentò nel 1499 di sfruttare il crescente successo che gli scritti di A. Ambrogini, il Poliziano, stampati a Venezia da Aldo Manuzio nel luglio 1498, avevano riscosso negli ambienti umanistici. Così impresse, sempre in formato in folio ma con falsa sottoscrizione («Florentiae, Leonardus de Arigis»), l’edizione pirata degli Opera del letterato toscano, a dispetto del privilegio concesso a Manuzio, il quale il 17 ott. 1502 si rivolse alla magistratura veneziana competente per ottenere giustizia. Non si ha notizia di alcun seguito della vicenda, anche se dai primi mesi dell’anno successivo il M. si trasferì a Verona – altra città priva di torchi dal 1487 –, dove diede alle stampe, in effimera società con l’incisore fiorentino Luca Antonio Degli Uberti, il Fioreto de le antiche croniche (della città di Verona), scritto da Francesco Corna da Soncino.
Il M. rientrò definitivamente a Brescia nei primi mesi del 1504; da quel momento, dismessa forse l’attività principale di tipografo, riservò la tiratura di forme tipografiche solamente a pochissime circostanze, limitando la produzione a testi di natura encomiastica. Così fu per l’orazione di Battista Spagnoli in morte del teologo carmelitano Pietro Nuvolani, dedicata alla marchesa di Mantova Isabella d’Este e stampata il 13 marzo 1504 a istanza di mastro Rondo De Rondi. Libraio e stampatore noto con il nome umanistico di Arundo de Arundi, il De Rondi pare avviasse il M. alla professione di libraio, rilevandone forse i torchi e l’attrezzatura tipografica.
L’ultima stampa conosciuta del M., un’opera antiquaria di Publio Vittore, è firmata 15 genn. 1509, data probabilmente non lontana dalla morte.
Il M. contrassegnò i propri prodotti con tre marche. La prima, a linea bianca, accompagnò le stampe uscite in società con Cesare da Parma: un cerchio, sormontato da croce a doppio braccio, diviso a metà, entro cui sono iscritte le iniziali «BM» e «CP». Adottata a partire dal Sallustio del 1495, la seconda marca, sempre a linea bianca, contiene solamente le iniziali «BM» che fiancheggiano un tronco d’albero mozzato da cui spuntano due germogli reggenti un cartiglio con il motto «Spes mea»: sopra il tronco trionfa il monogramma «IHS». La terza marca, a linea nera, ritrae due putti adoranti il monogramma di Cristo, posti su di una corona al di sotto della quale figurano le solite iniziali. L’incisore Degli Uberti ideò una marca per siglare la propria collaborazione con il M.: la Fortuna, assisa su un globo (al cui fianco stanno le iniziali «LAF» [Luca Antonio Fiorentino] e «BM»), mentre tiene fra le mani le cime e l’albero reggenti una vela gonfiata dal vento.